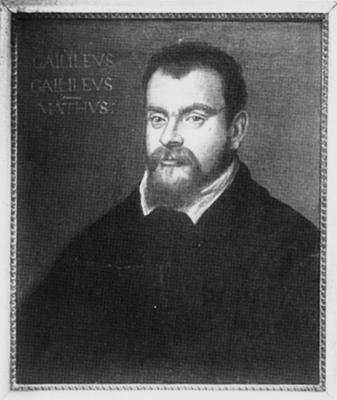
LA FORTUNA
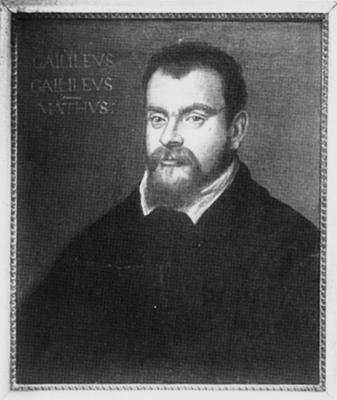
GALILEI NEL XVII SECOLO
Il pensiero filosofico e scientifico di Galilei, il metodo
matematico sperimentale, la battaglia copernicana determinano in
modo prevalente la fortuna dello scienziato.
Durante il Seicento, mentre la Chiesa condannava l’eresia di
Copernico e contestava Galileo, gli allievi della scuola
galileiana continuano l’indagine del maestro, dissimulando
però le implicazioni filosofiche della sua ricerca e astenendosi
dal riprenderne esplicitamente le idee astronomiche e
cosmologiche.
La repressione ecclesiastica risulta efficace oltre che in Italia
anche negli altri paesi cattolici: infatti, dopo la condanna del
Dialogo di Galileo, anche il filosofo francese Cartesio rinuncia
alla pubblicazione del proprio trattato Il Mondo di ispirazione
copernicana. Nonostante ciò nulla impedì la pubblicazione delle
opere meno copernicane di Galileo nel 1655-56 a Bologna.
IL SETTECENTO E L’ILLUMINISMO
Valutare la fortuna di Galileo nel Settecento risulta alquanto
più complesso. In Italia prevale all’inizio del secolo il
conformismo anticopernicano, tranne in alcuni ambienti come
Napoli dove, sotto lo stimolo dell’attività degli
Investiganti, viene pubblicato clandestinamente nel 1710 il
Dialogo.
E se già Muratori e Vico (Scienza Nuova) riconoscono
l’importanza della riforma sperimentale del sapere di
Galilei, Francesco Algarotti (Newtonianesimo spiegato alle dame)
e Paolo Frisi (Saggio sul Galileo) giungono ad una definita
coscienza del valore dello scienziato.
Negli scritti dei filosofi illuministi, Galilei è spesso
associato a Bacone, Cartesio, Newton e Locke come precursore
delle idee illuministe. D’altra parte la venerazione dei
lumi per Galilei non conosce confini; David Hume, empirista
inglese apprezza oltre alla sua scienza e alla sua filosofia, la
“vivacità” dello stile e la “piacevolezza”
della scrittura, e il tedesco Immanuel Kant gli conferisce il
merito di aver portato la fisica “a trovare la strada
maestra della scienza”.
L’OTTOCENTO TRA ROMANTICISMO E POSITIVISMO
Nell’Ottocento il messaggio di Galileo viene assimilato
dalla cultura italiana, basti pensare ai Sepolcri e alle Grazie
di Foscolo. Lo scienziato in ambito romantico e risorgimentale
diventa quasi un eroe e Gioberti nel Primato lo considera il vero
padre delle scienze sperimentali perché aveva scoperto cose
meravigliose, a differenza di Bacone che non aveva scoperto
nulla. In questo secolo suscita interesse anche la prosa di
Galileo, apprezzata dal Leopardi per la precisione e
l’eleganza e criticata da De Santis il quale, pur
attribuendogli “uno stile tutto cose e tutto pensiero”,
condanna il carattere convenzionale del suo toscanismo
classicheggiante “forma pietrificata
dall’abitudine” priva di eccessi barocchi, ma anche
priva di vita.
In Europa, l’interpretazione dell’opera di Galilei è
al centro della riflessione del positivismo sui fondamenti del
sapere scientifico. Così Comte nota come la filosofia naturale
si sia staccata dalla metafisica e sia diventata importante dopo
le scoperte di Galileo sulla caduta dei gravi.
IL NOVECENTO
All’inizio del Novecento Benedetto Croce sottolinea
l’approccio antimetafisico alla natura e l’eliminazione
delle “stravaganti filosofie della natura che non sono né
scienza né filosofia”. Per il neokantiano tedesco Ernst
Cassirer il merito di Galileo sta nell’aver capito che le
leggi scientifiche non sono ricavabili dall’esperienza,
anche se le loro conseguenze sono applicabili alla realtà
esteriore. Il filosofo tedesco Edmund Husserl scorge nel
matematismo di Galilei l’inizio della crisi delle scienze
matematiche europee, dovuta al fatto che esse sovrappongono il
loro mondo geometrico al mondo reale, nascondendolo al nostro
sguardo. Karl Popper mette in luce l’aspirazione di Galilei
di una scienza capace di una vera descrizione del mondo e dei
fatti osservati mentre Paul Feyerabend, negando l’esistenza
di un metodo della scienza, valorizza la spregiudicata capacità
di Galilei di imporre idee innovative.